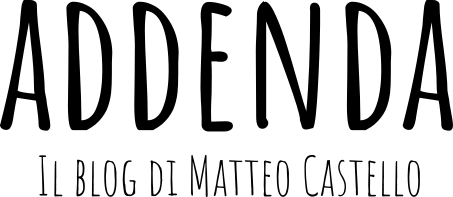Ogni anno si può individuare una manciata di artisti su cui
tutti si trovano d’accordo. Se l’anno passato era impossibile non parlare di FKA twigs, War On Drugs e Sun Kil Moon,
questo 2015 ha visto il trionfo di nomi come Kendrick Lamar, Sufjan
Stevens, Courtney Barnett e Father John Misty. Il ventaglio dei “satelliti”, però, è sempre più vario: e
qui viene il bello. I dieci dischi che elenco di seguito sono una selezione
degli ascolti più interessanti dell’anno ormai agli sgoccioli. Attenzione però,
come tutte le classifiche qui non c’è niente di fisso o esaustivo: tra gli
esclusi degni di attenzione sento di segnalare il bel pasticcio psichedelico di
Miley Cyrus (“Miley Cyrus & Her Dead Petz”), l’ottimo ritorno dei Deerhunter (“Fading Frontier”), il coloratissimo lavoro dei colombiani Bomba Estéreo (“Amanecer”) e il magnetico esordio di LA Priest (“Inji”),
senza dimenticare Dawn Richard (“Blackheart”) e 2814 (“新しい日の誕生”).
Ma ecco i miei 10: