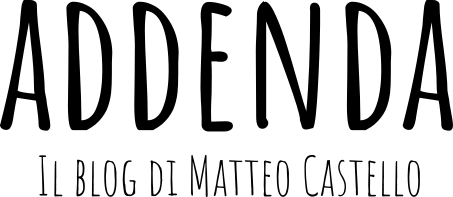Mi
stropiccio gli occhi ed esco lentamente dal letargo. Dove sono? Una coltre di
luce mi circonda e mi impedisce di distinguere il sole dai muri color pastello
che mi circondano. Lentamente i riflessi accecanti si attenuano, le mie pupille
si stringono e smettono di fissare il vuoto.
Sono
in una stanza d’ospedale, che sia ancora tutto un sogno? Le pareti mezze
bianche mezze azzurrine mi circondano come camici bianchi. Sono a letto, solo
in una stanza vuota. Dalla finestra entra una luce accecante, calda e viva.
Intravedo slanci di pioppi da qualche parte là fuori. Un formicolio mi assale
gambe e braccia costringendomi a paralizzarmi all’istante. Fitte cominciano a
pervadermi il corpo e tutto d’un tratto passo dal mio risveglio stupito alla
mia sofferenza più atroce. Sembra che il mio corpo si stia risvegliando
lentamente da anni di forzata paralisi. Le mie dita chiedono di afferrare
qualcosa, le mie gambe vogliono correre, le mie braccia dimenarsi e perfino la
lingua non ne vuol sapere di calmarsi. Il mio corpo che chiede vita. Movimento.
Fulmini
cremisi di dolore mi s’infilano tra ossa e muscoli, per non pensarci stringo i
denti e fisso l’armadio di metallo di fronte a me. Con rabbia. Sei tu la fonte
del mio dolore, io ti ripudio, ti bandisco, vattene. Convulsioni. Il dolore si
fa insopportabile, un picco lancinante e poi, lentamente, i lampi scemano in
ruggiti isolati e la mia mascella si rilassa. Mi sento accaldato, questo
tremendo risveglio mi ha fatto sudare freddo. Altre fitte mi scuotono ma questa
volta sono docce gelate. Fremiti scomposti. Guardo le mie dita mentre le muovo,
le apro, le chiudo, testo le mie nuove capacità. Sembrano a posto. Muovo quelle
dei piedi sotto le coperte e anche quelle sembrano essere tutte intere e
funzionanti. Mi sposto su un fianco, poi l’altro. Tutto ok.
Ma
allora che ci faccio in un ospedale? Aspetto che le risposte entrino, in camice
bianco, e mi facciano chiarezza.